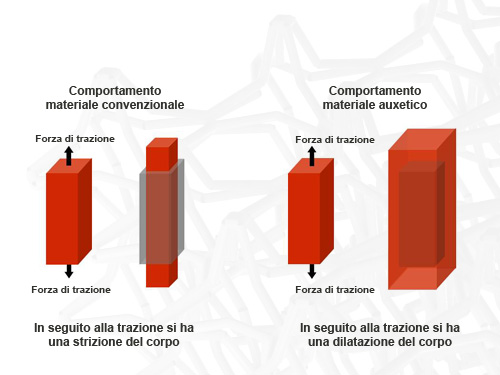Leonardo da Vinci progettò diverse macchine studiando attentamente la natura. Ciò perchè l’evoluzione naturale procede in accordo con le sue stesse leggi e compatibilmente alle sue possibilità e limitazioni. Nell’articolo che segue riportiamo alcuni esempi di materiali, tecnologie e strutture che sono stati realizzati imitando la natura per ottenere caratteristiche superiori. Stiamo parlando quindi di esempi di “biomimetica” (vedi l’articolo: Che cos’è la Biomimetica?).
Le note fibre sintetiche come il nylon sono ispirate alla seta naturale. Il velcro è ispirato alla forma uncinata dei semi vegetali. Imitando le zampe del geco sono stati realizzati adesivi nanostrutturati.
Ispirandosi alla superficie dei fiori di loto è stato possibile realizzare superfici autopulenti. La struttura superficiale dei fiori di loto infatti è molto fine ed è rivestita di cristalli di cera idrofobica di diametro pari a circa 1 nanometro (1 milionesimo di millimetro). Su una foglia di loto solo il 2-3% di una goccia d’acqua è realmente a contatto con la foglia stessa. La nanostruttura ruvida delle foglie di loto è essenziale affinché l’acqua non scivoli ma rotoli sulla superficie, ciò le permette di portar via con sé una quantità nettamente maggiore di sporco ed impurità.
I più recenti rivestimenti di superficie, già usati in ingegneria aerospaziale per ridurre l’attrito idrodinamico, hanno la struttura che imita quella dell’epidermide dei grandi pesci. Un esempio evidente si ha nel campo del nuoto agonistico dove gli atleti indossano tute speciali per migliorare le proprie prestazioni. La rugosità della pelle dello squalo, ad esempio, offre una migliore portanza nel nuoto.
Il muco che riveste la pelle di alcuni animali acquatici (vedi il barracuda) ha una doppia funzionalità: agisce da barriera contro la salinità dell’acqua ed opera una riduzione della drag force (forza di trascinamento). Questa proprietà è stata sfruttata per produrre additivi polimerici artificiali i quali, immessi nelle tubazioni di oleodotti in Alaska, hanno permesso di ridurre del 30% la potenza richiesta dalle pompe per il sostentamento dell’olio.
La vernice autoriparante, oggi disponibile su diverse berline di lusso, consiste in un composto formato da un polimero capace di rigenerarsi se sottoposto alla radiazione ultravioletta presente nella luce solare. Combinando il poliuretano con una molecola di chitosano, un carboidrato che si trova nella corazza dei crostacei (granchi e aragoste), i ricercatori hanno ottenuto proprietà auto-riparanti. Quando il materiale è danneggiato, la resina viene rilasciata nella frattura ove solidifica al contatto con un agente indurente presente nel materiale. Questo, una volta esposta la superficie alla radiazione ultravioletta, crea legami di reticolazione al fondo della frattura sanandola in un ridotto arco di tempo.
L’atomo di carbonio, la molecola dell’acqua, le proteine, le cellule, i tessuti, gli esseri umani e tutte le creature viventi usano il principio della tensegrità (ovvero minimo sforzo per massimo rendimento) per la loro struttura. Questo significa che la stabilità delle loro strutture non dipende dalla resistenza di ogni singolo componente, bensì dal modo in cui l’intero sistema distribuisce e bilancia le sollecitazioni. Il termine tensegrità (tensione + integrità) sta ad indicare la stabilità a tensione e compressione ottenuta mediante la distribuzione ed il bilanciamento delle forze all’interno della struttura. Una cupola geodetica, ad esempio, è in grado di sopportare un dato carico con il minimo impiego di materiale, pur essendo essenzialmente formata da montanti rigidi che compongono triangoli, pentagoni, ecc., ognuno dei quali è in grado di resistere sia a trazione che a compressione.
Le particolari performances proprie dei materiali biologici sono il frutto di una lenta e severa selezione naturale che opera nell’intento di trovare il miglior materiale disponibile per una precisa funzione. Contrariamente a quanto si possa pensare, la tendenza è quella di dotare un organismo di un numero limitato di componenti o principi che possano svolgere differenti ruoli. Ad esempio il collagene di tipo I presenta una diversa morfologia a seconda della funzione che svolge nei vari tessuti. Questa proteina mostra bassa rigidità ed elevata deformazione, tipica dell’elastomero, nei tendini. Nella cornea offre proprietà ottiche come la trasparenza. Infine nell’osso, dove è associato a cristalli di idrossiapatite (vedi l’articolo: Materiali compositi: le ossa), conferisce durezza e resistenza. Molti e molti più esempi si potrebbero fare in merito alla biomimetica, tuttavia, per semplicità, ci siamo limitati a riportarne solo alcuni tra quelli più facilmente comprensibili.
Note. Potrebbe esserti utile leggere l’articolo “Fattore di moltiplicazione” per valutare a quanto corrisponde 1 nanometro (nm).

Solo il 2-3% della superficie di una goccia d’acqua entra in contatto con la superficie della foglia di loto.
La nanostruttura ruvida delle foglie di loto è essenziale affinché l’acqua non scivoli ma rotoli sulla superficie,
ciò le permette di portar via con sé una quantità nettamente maggiore di sporco ed impurità.
Su questo principio sono state sviluppate superfici autopulenti artificiali.
Image’s copyright: bad & heizung (www.bad-heizung.de)